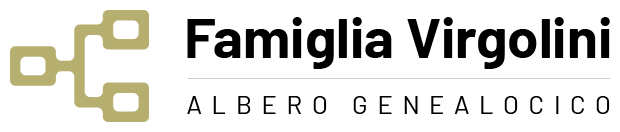Presentazione
Gli ultimi trent’anni hanno assistito alla crescita della fortuna delle ricerche genealogiche. Non quelle tradizionali del passato, che riguardavano le famiglie nobili e nobilitate dai soldi accumulati e che hanno fatto la fortuna di molti genealogisti di professione. Si tratta di nuove ricerche rese possibili (e quasi sollecitate) da due avvenimenti che hanno riguardato il mondo degli archivi. La disponibilità di documenti anagrafici raccolti dai Comuni, la maggiore disponibilità di documentazione prodotta dalle parrocchie.
I primi sono ora visibili in rete, nel Portale Antenati (https://antenati.cultura.gov.it), che ha messo a disposizione di chiunque sia interessato i registri dell’anagrafe comunale (nati, matrimoni, morti) di un gran numero di comuni italiani, a partire dall’Unità d’Italia ma in alcuni casi la documentazione risale più indietro, al periodo napoleonico. Sono documenti ora raccolti nei depositi degli Archivi di Stato che negli anni passati hanno cominciato ad essere digitalizzati e messi a disposizione dei ricercatori e dei cittadini.
Gli altri documenti, quelli prodotti dalle parrocchie a partire dal XVI secolo – e si tratta dei registri di battesimo, di cresima, di matrimoni, dei morti e gli “stati delle anime” (una sorta di censimento rinnovato ogni anno) – cominciano ad essere più accessibili che in passato e sono conservati sempre più spesso o nelle sedi delle foranie o vicarie (che raggruppano più parrocchie della stessa Diocesi) o negli Archivi diocesani che sono frequentemente aperti alla consultazione del pubblico e degli studiosi. Attraverso questo tipo di fonti le ricerche per la costruzione di alberi genealogici delle famiglie italiane hanno fatto molta strada e stanno diventando un fenomeno di costume.
Questo portale, che abbiamo intitolato “Storie di famiglie”, considera l’albero genealogico un punto di partenza, non il punto di arrivo delle ricerche.
La realizzazione di un albero genealogico porta con sé una serie di domande: perché certi nomi di persona si ripetono? cosa influenza la scelta del nome proprio? perché quegli antenati si sono spostati da un paese all’altro? perchè tanti bambini morivano in tenera età? i nostri antenati che lavori facevano? com’erano fatti i paesi dove hanno vissuto? qual era il grado di istruzione dei nostri antenati?
Sono domande che non hanno risposta nell’albero appena terminato. E spingono la ricerca oltre l’albero genealogico. L’obiettivo di queste pagine è appunto andare oltre.
In primo luogo si vorrebbe ristabilire una conoscenza dei fatti e delle persone che oggi sembrava non più possibile dato che le trasformazioni degli ultimi due secoli hanno disseminato i discendenti dei capostipiti in giro per il mondo. Le tecnologie degli ultimi vent’anni consentono però oggi di rimettere in comunicazione anche quotidiana, anche continua, persone che stanno ai quattro angoli di una provincia, di una nazione, dell’intero pianeta. E quindi consentono di far incontrare, di far conoscere, di condividere quello che in un passato nemmeno troppo lontano era naturale perché si abitava nella stessa casa o nello stesso paese o nello stesso territorio. Le persone che appartengono alle ultime tre-quattro generazioni di discendenti dallo stesso capostipite oggi possono riconoscersi e, se vogliono, stabilire dei contatti. L’albero genealogico è una specie di biglietto di presentazione: quello che segue – se segue – è l’avvio di un contatto con chi è un nostro lontano parente o affine che le nuove tecnologie rendono possibile.
Altro obiettivo è quello di costruire la storia intorno all’albero genealogico. Le risposte a quelle domande formulate sopra sono una traccia per capire le vicende della vita dei nostri antenati: in che luogo, in che mondo, in che lavoro, in che cultura, in che fede religiosa, in che abitudini hanno speso la loro esistenza? quali sono stati i loro problemi del vivere quotidiano? e come gli eventi nazionali e internazionali hanno avuto un ruolo nelle loro decisioni? come hanno vissuto la fine del mondo agricolo tra Ottocento e Novecento? e quali conseguenze hanno avuto sulle loro vite le due Guerre mondiali?
Per giungere a dare risposte a queste e ad altre domande che possono sorgere pensiamo possano essere molto utili le fotografie, le lettere, le testimonianze che i nostri antenati hanno lasciato. E quando questi documenti non basteranno si dovranno aggiungere i risultati di letture di giornali, di articoli, di libri che ci aiuteranno ad integrare quelle testimonianze e quelle lettere.
In questo modo pensiamo sia possibile arrivare a capire meglio anche lo stesso albero genealogico perché intorno a quei nomi e a quelle date, a quelle relazioni di parentela, ci avremo aggiunto molti frammenti della storia di una famiglia.
La famiglia che avvia questo Portale è quella che trae origine da Pietro Virgolini e Domenica Minigutti. già residenti a Jalmicco dove si erano sposati nel 1804 e poi trasferitisi a Sevegliano tra il 1846-1847 (tutte località del medio Friuli) . Da qui i loro discendenti si sono sparsi per il Friuli, poi in Italia, Europa, resto mondo. Altri Virgolini sono rimasti a Jalmicco, altri sono vissuti sempre altrove. Ma quelli non fanno parte di questa ricerca.
E questo è l’obiettivo che si propone la nostra pagina che viene offerta ai Virgolini di Jalmicco e Sevegliano ma anche a tutti coloro che sono interessati alla storia della loro famiglia.